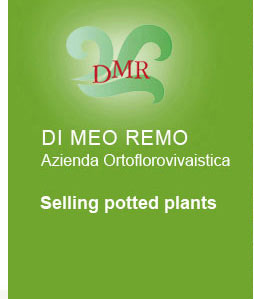La barriera lungo il confine tra gli Stati Uniti ed il Messico é una linea separatoria sia fisica che virtuale.
Essa può essere un’icona dei muri reali e mentali che si stanno alzando a livello internazionale. Queste differenti tipologie di recinzioni (e restrizioni) stanno condizionando negativamente il dialogo, l’economia, la democrazia a livello mondiale. Si prenda come esempio il Mediterraneo.
Esso non é un blocco unitario e di immediata lettura. In primo luogo, da un punto di vista geografico, esso é posto nel punto di congiunzione tra Asia, Africa ed Europa. Inoltre l’area del mare nostrum si è recentemente allargata, rispetto a quella strettamente fisica, comprendendo anche zone interne e contigue rispetto ai Paesi rivieraschi.
Questo significa che crisi ed instabilità possono ripercuotere i loro effetti su aree più lontane, favorendo l’influenza di poteri geograficamente distanti, che precedentemente avevano avuto scarsa importanza. Il Mediterraneo riacquista, in questo modo, una centralità strategica, contrariamente a quanto accaduto in un passato prossimo, all’interno di un quadro geopolitico complesso ed articolato che ha visto aggiungersi alle tradizionali triangolazioni dell’Europa, del Nord America e dell’Africa, anche quelle della Cina, della Russia, oltre che dell’India. Nella mente torna un proverbio cinese che recita: "Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento", ponendo l’accento sul fatto che, di fronte alle sfide o alle trasformazioni, vi é la possibilità di una scelta.
Seguendo la scia descritta, l’Associazione “Donne e Società” ha organizzato a Roma un convegno sul valore del dialogo e della diplomazia nell’affermazione del diritto alla pace. L’approccio metodologico dell’evento é stato quello della “sentinella” (in questo caso il nostro incontro) che rifiuta il ruolo di “indovino” sul futuro per affermare quello di colui che dialoga, che suggerisce di continuare ad interrogarsi, di porre delle domande a cui cercare le risposte. Attraverso un metodo multidisciplinare, si é cercato di evidenziare la complessità dei fattori che possono influire sul tema in oggetto ed illustrare alcune strategie internazionali adottate per affrontarlo.
Tra i qualificati relatori si ricordano l’On Silvia Costa, già Presidente Commissione Cultura del Parlamento Europeo; l’Ambasciatore Maurizio Melani, già Direttore Generale Affari Esteri; la Prof.ssa Anna Caimati Hostert, filosofa e docente universitaria negli Stati Uniti ed in Italia (in foto). Moderatrice del convegno é stata la Dott.ssa Donatina Persichetti, già Presidente dell’Associazione “Donne e Società”. Al termine dell’evento ci ha gentilmente concesso un’intervista l’On Silvia Costa, la quale ha affermato che: “Rimettere al centro il valore del dialogo e della diplomazia per l’affermazione della pace significa ripartire dalla ragione di fondo da cui - dopo la Seconda Guerra mondiale, il nazifascismo e l’orrore della Shoah - si è avviato il processo che, in nome del “mai più “alla guerra, ai nazionalismi e alle dittature, ha dato vita alle Nazioni Unite nel 1945, all’adozione delle Carte Costituzionali nazionali in Europa (nel 1947 in Italia ) e in altri Stati, alla Dichiarazione ONU sui diritti umani nel ‘48 seguita dalla Convenzione europea del 1950 del Consiglio d’Europa, istituito l’anno prima, l’ approvazione fin dal 1949 delle Convenzioni di Ginevra (su prigionieri di guerra, rifugiati, protezione dei civili in tempo di guerra, status delle organizzazioni umanitarie ecc), fino alla creazione in Europa della CECA nel 1951 e quindi nel 1957 della CEE tra 6 Paesi fondatori. La libertà e la dignità della persona umana, la democrazia, la cooperazione internazionale, lo sviluppo, la giustizia sociale e la pace come condizione e fine sono i valori alla base di questa sempre più ampia e complessa architettura istituzionale e delle Carte fondamentali.
Anche per questo la Comunità, ora Unione Europea a 27, ha goduto di 80 anni di pace e di intense relazioni internazionali nell’ambito della alleanza Nato con intento difensivo, considerando il quarantennio della guerra fredda tra i due blocchi. Tuttavia, la storia recente ha dimostrato quanto sia fragile questo equilibrio, e quanto le conquiste faticosamente raggiunte possano essere messe in discussione da crisi geopolitiche, nuove forme di conflitto, minacce ibride e derive autoritarie che tornano a insidiare il tessuto democratico europeo e mondiale.
In un contesto globale attraversato da tensioni e incertezze, riaffermare la centralità del dialogo e della diplomazia significa non solo custodire la memoria delle tragedie del passato, ma anche innovare continuamente gli strumenti di cooperazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti. Oggi sono 56 i conflitti nel mondo tra cui quelli tragici e vicini in Palestina dopo la brutale aggressione di Hamas a Israele e quello scatenato in Ucraina, ai confini della UE, da Putin con una aggressione armata unilaterale tre anni fa. A queste guerre armate si è aggiuta la minaccia ondivaga di Trump con le guerre commerciali sui dazi e il neo nazionalismo USA che guarda al Pacifico e non solo non mostra più interesse all’Europa, ma è addirittura ostile. A queste minacce interne ed esterne non si può che rispondere su più piani, con realismo ma non dimenticando le ragioni etiche e politiche che rendono l’Europa un modello sociale, democratico e solidaristico unico nel panorama mondiale. Certamente costruendo una difesa integrata europea a tutela della nostra sicurezza e della nostra democrazia ma anche per azioni di peace keeping e di prevenzione di conflitti.
Ma nella direzione della costruzione di una politica estera europea e di una maggiore autonomia europea pur nell’ambito della NATO. Ma non basta. Occorre rilanciare e ampliare le relazioni commerciali e industriali internazionali come l’accordo con l’ASEAN, il Mercosur e in corso con l’India, non solo per rendere più competitiva la nostra economia ma anche per il modello delle relazioni di cooperazione e non di chiusura e di protezionismo. Vanno intensificate le relazioni culturali e scientifiche specie verso le giovani generazioni dei Paesi vittime di aggressioni e in conflitto, ma anche in risposta alla chiusura e definanziamento delle relazioni accademiche e di ricerca imposte da Trump verso i giovani di altri Paesi, rendendo attrattive le nostre università e centri di ricerca e le imprese che puntano sulla innovazione. Occorre creare ponti culturali, anche per evitare la spirale di odi e vendette anti occidentali o conflitti religiosi messi in moto in tante aree del mondo, anche con forme di cooperazione e di tutela del patrimonio culturale e religioso distrutto dalle guerre e di cui l’italia in particolare ha un know how ineguagliabile nel mondo. È fondamentale promuovere una cultura della pace che coinvolga le nuove generazioni, investendo nell’educazione ai valori del rispetto, della solidarietà e della cittadinanza responsabile.
E ci sono strumenti europei per farlo: penso al Corpo europeo di solidarietà, in EU e in Paesi terzi, rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni, o ai corpi umanitari, o alla esperienza dei “corridoi universitari”, il programma che proposi nel 2015 in Parlamento EU e che ora è diventato una realtà in tante università italiane ed europee di cooperazione con studenti sfollati o rifugiati, adottato dall’UNHCR. Penso anche a Erasmus Mundus e a Europa creativa che sostiene progetti culturali tra SM e con altri Paesi terzi. Penso alle borse di studio Marie Curie e ai progetti per giovani ricercatori del programma Horizon EU. Solo così sarà possibile consolidare un ordine internazionale fondato sui diritti umani, sul rispetto delle diversità e sulla ricerca costante del bene comune. La sfida attuale, quindi, consiste nel saper tradurre quei principi fondativi in azioni concrete, capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo e di costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutte e tutti. Dopo ci ha gentilmente concesso un’intervista l’Ambasciatore Maurizio Melani, il quale ci ha comunicato che: “L'incontro promosso da Donne e Società sul valore del dialogo e della diplomazia per l'affermazione del diritto alla pace, aperto dalla Presidente Donatina Persichetti e diretto e animato dall'Onorevole Silvia Costa, ci ha consentito un ampio dibattito sulle maggiori crisi in corso e su come si puo' operare per prevenire, gestire e risolvere conflitti ripercorrendo quanto la storia ci ha insegnato. In tale ambito si e' rilevato quanto sia importante in situazioni specifiche il ruolo delle donne nel favorire processi di pacificazione e riconciliazione stimolando dal basso l'azione della societa' civile e dei Governi. Abbiamo esaminato come l'aggressione russa all'Ucraina, in flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e del Memorandum di Budapest del 1994 che garantiva l'integrità' territoriale del paese, rispondesse ad un disegno di recupero del controllo russo dei territori dell'ex-Unione Sovietica annunciato da Putin a Monaco nel 2007.
Abbiamo tuttavia anche visto che gli accodi di Minsk mediati da Germania e Francia dopo l'occupazione russa della Crimea nel 2014 e attraverso mercenari di aree del Donbas, non siano stati osservati ne' dalla Russia che non ha ritirato quei mercenari, ne' dall'Ucraina che non ha disposto la prevista autonomia delle province russofone all'interno del paese. Distratti da altre vicende non vi e' probabilmente stata da parte degli occidentali una sufficiente attenzione, con relative pressioni, per fare osservare gli accordi da entrambe le parti cercando di evitare quel che e' poi accaduto. L'attacco in profondita' russo nel 2022 per il controllo dell'intero paese e' stato fermato dalla resistenza ucraina sostenuta da incrementali ma a volte tardivi aiuti americani ed europei.
Di fronte al sostanziale rifiuto russo di negoziare un accordo basato sulla situazione sul terreno che comporterebbe comunque dolorosi sacrifici per l'Ucraina, non resta purtroppo in questa fase che continuare ad aiutare Kiev a resistere essendo chiaro che nessuno dei due belligeranti puo' vincere e che l'indipendenza del paese aggredito va preservata per la sicurezza dell'Europa ed in particolare delle sue parti piu' esposte alla minaccia russa, non rinunciando tuttavia a dispiegare azioni diplomatiche per giungere ad una pace giusta e rispettosa del diritto internazionale. Abbiamo anche esaminato la situazione in Medio Oriente aggravata dell'attacco israeliano all'Iran motivato dall'esigenza di fermare il programma nucleare iraniano ed anche dalla volontà' di abbattere quel sanguinario regime, osteggiato dalla maggioranza della popolazione, senza pero' tenere conto di quelle che potrebbero essere le conseguenze per tutta la regione ed oltre di un collasso senza una organizzazione politica dell'opposizione in grado di gestire la transizione e governare, evitando quanto accaduto in altri paesi dell'area dopo crolli di regimi imposti dall'esterno con le armi. E' incoraggiante che gli europei piu' direttamente impegnati nella questione abbiano avviato un dialogo per giungere all'inibizione dell'acquisizione della bomba atomica da parte dell'Iran, nel rispetto di quanto previsto dal Trattato di Non Proliferazione, che era garantita dall'accordo con stringenti controlli sui livelli di arricchimento dell'uranio, concluso nel 2015 tra Teheran da un lato e i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite piu' la Germania e l'Unione Europea dall'altro.
Il ritiro unilaterale di Trump dall'accordo durante il suo primo mandato ha dato spazio alle tendenze piu' oltranziste del regime iraniano che ha iniziato ad arricchire uranio assai oltre i limiti previsti fino ad un livello vicino a quello per la produzione di armi nucleari. L'azione diplomatica degli europei parti dell'accordo va quindi sostenuta anche dopo la decisione di Trump, successiva al nostro incontro, di intervenire nei bombardamenti. Nello stesso tempo si e' rilevato che devono cessare le inaccettabili stragi e distruzioni a Gaza, con decine di migliaia di vittime e centinaia di migliaia di feriti e costrizioni alla fame e alle malattie, di cui sono responsabili l'attuale Governo israeliano e Hamas, nonche' le violenze e le appropriazioni di terre in Cisgiordania ai danni della popolazione palestinese. Anche qui e' necessaria una determinata azione diplomatica per porre fine alla guerra e giungere alla completa liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, riavviando anche il processo per la soluzione Due Popoli e Due Stati in sicurezza reciproca, che trova tuttavia ostacoli nell'erraticita' e nelle continue contraddizioni dell'Amministrazione Trump.
Si e' infine rilevato, con lo stimolo della Dottoressa Susanne Diku Mbye Vicepresidendte Donne e Società, che vanno superati doppi standard, spesso ispirati da visioni eurocentriche, nelle valutazioni e nelle azioni da intraprendere di fronte ad ingiustizie, minacce alla pace e alla sicurezza internazionale e gravi violazioni dei diritti umani. Azioni che dovrebbero ispitarsi sempre a criteri di equita' e proporzionalita'.” Successivamente anche la Prof.ssa Anna Caimati Hostert ci ha gentilmente concesso un’intervista, nel corso della quale ella ha esplorato la prospettiva delle donne nell’affrontare i conflitti. Il punto di partenza é stato il pensiero che Virginia Woolf ha esposto in due sue famose opere: “Le tre ghinee” e “Pensare la pace durante un raid aereo”. In questi testi l’autrice inglese si pone il quesito di come difendere se stessa, il marito Leonard, ebreo e, in generale, l’Europa, dalle mire espansionistiche hitleriane. Una prima riflessione riguarda il fatto che concetti quali patria ed eroismo in battaglia siano profondamente presenti nella nostra cultura. Alcuni esempi emblematici sono la mitizzazione delle figure di Achille, di Alessandro Magno. A questo fascino di Ares non si sottrae neanche l’uomo moderno, come evidenziato dal libro di James Hillman intitolato: “Un terribile amore per la guerra” in riferimento anche ad alcune forme di comunicazione. Al contrario, Virginia Wolf afferma che combattere il patriarcato è anche combattere lo spirito che conduce alla guerra: “Noi donne non abbiamo una patria”, ovvero le donne non hanno le armi da fuoco degli uomini, la loro autentica arma per la libertà é la forza delle loro idee, il loro combattimento é con la mente.
Questo significa che la logica della guerra é come un nodo scorsoio che soffoca il respiro ed uccide, per cui servirebbero pensiero e politica: ma cosa dire in riferimento a questi due termini rispetto a coloro che sono al vertice del potere? Successivamente la Prof.ssa Caimati Hostert ha svolto considerazioni politico-culturali in base alla sua trentennale esperienza di filosofa e teorica di studi visuali, senza dimenticare che ha anche la cittadinanza americana e vive una parte dell’anno negli USA. Ella ha raccolto l’invito della dott.ssa Susanne sottolineando che il focus degli studi visuali nella cultura americana partono proprio da un’immagine anticolonialista. Questo perché gli USA sono nati dalla ribellione al colonialismo inglese. Pertanto al cuore degli studi visuali vi é il colonialismo, ed in particolare l’immagine di un Paese martoriato dal colonialismo europeo: il Congo, e che troppo spesso si guarda ai processi storici con la prospettiva della cultura europea. Dopo la Prof.ssa Caimati Hostert si é soffermata su alcuni elementi fondamentali che si stanno incrinando, nell’ultimo periodo, nella democrazia americana. Il riferimento é alla concentrazione di potere in una sola persona che é al vertice del potere esecutivo, ha la maggioranza in quello legislativo ed ha nominato una buona parte dei rappresentanti di quello giudiziario. A rischio, in sostanza, é il sistema “Check and balance” (controllo e bilanciamento dei poteri dello Stato n.d.r.) che assicura l’equilibrio tra i poteri dello Stato e previene abusi da parte di uno dei tre. Un’ultima riflessione riguarda il pensiero del gesuita spagnolo Balthasar Graciàn.
La sua opera “Oracolo manuale ovvero l’arte della prudenza” fu un grande manuale x la diplomazia, scritto per essere seguito dai potenti ma che fu criticato dalla gerarchia gesuita che lo ritenne “troppo laico”. Per questo Gracian pagò un prezzo altissimo che lo portò addirittura alla morte. Per svariati motivi è stato un gesuita molto noto ai regnanti francesi ed in particolare quelli spagnoli. Graciàn fu un uomo di raro acume politico e visionario di una geopolitica e diplomazia che si sono affermate molto tempo dopo i suoi scritti. In questi ultimi é forte la consapevolezza della lotta che l’eroe deve combattere in primo luogo nel suo intimo. La sua forza di volontà e la sua capacità di autocontrollo nella gestione degli eventi che deve affrontare rappresentano il suo valore.
Nel pensiero di Graciàn é presente un’eco della dialettica heideggeriana, dell’apparire e del velarsi, del lento scoprire la verità per gradi. Non si tratta di un gioco al nascondimento, ma della capacità di saper dosare e misurare la realizzazione della propria strategia con acume e saggezza.